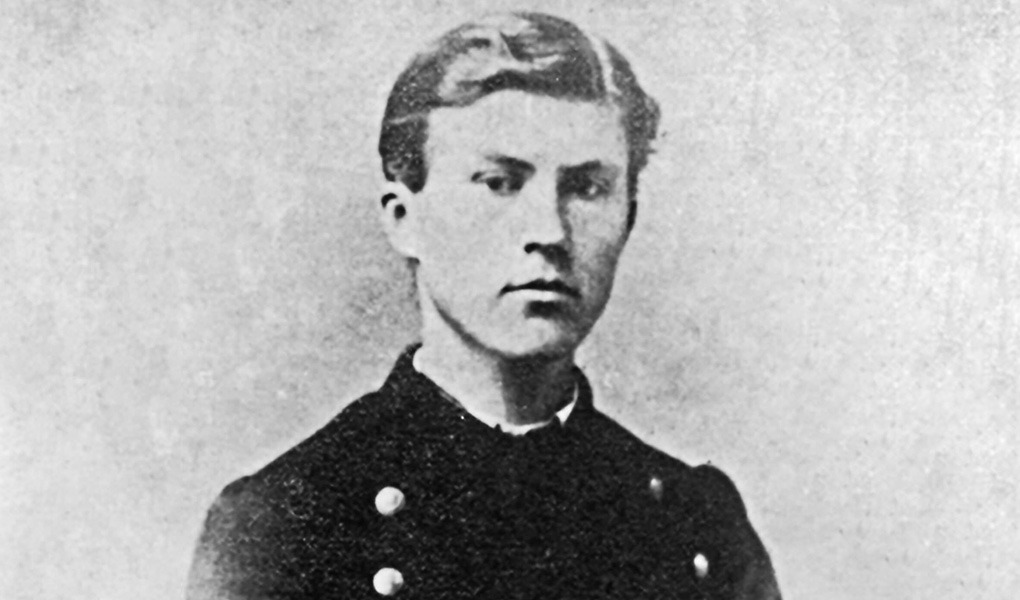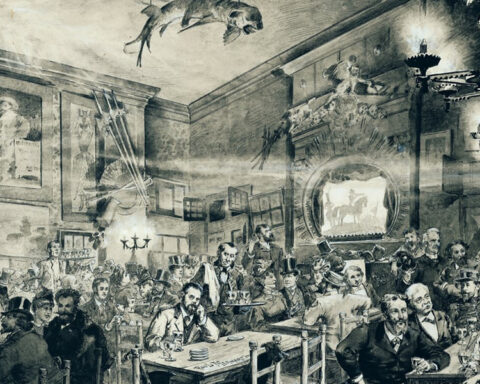Professore di filosofia, etnografo, ma anche traduttore. Georges Hérelle (1848–1935) è l’uomo dietro alle prime traduzioni francesi di alcune opere di scrittori italiani quali Grazia Deledda, Antonio Fogazzaro, Matilde Serao e soprattutto Gabriele d’Annunzio. Grazie a Hérelle, la Francia scopre d’Annunzio a partire dal 1892 e di rimbalzo l’Italia il suo Vate, che in una lettera del 2 maggio 1894 indirizzata al traduttore francese scrive: «Ormai il vostro nome è legato per sempre al mio; noi siamo una sola persona».
Nato a Pougy-sur-Aube, Hérelle ha sempre mostrato uno spiccato interesse per la letteratura e per i viaggi che, grazie anche ai numerosi permessi ottenuti dai suoi superiori nei licei in cui insegna, compie durante il corso di tutta la sua vita, tra Francia, Belgio, Inghilterra, Svizzera, Italia, Grecia, Spagna e Africa del Nord.
Precursore della storia dell’omosessualità maschile, documenta, archivia e scrive numerosi testi, usando diversi pseudonimi, fino al 1903, quando intraprende un vero e proprio lavoro di archeologo della sessualità completando Histoire de l’amour grec, opera di M.H.E. Meier (1796–1855). Parallelamente a queste pubblicazioni sul tema, costruisce una biblioteca atipica, in gran parte conservata presso la Mediateca Jacques-Chirac di Troyes: oltre a una prolissa corrispondenza con un’ampia cerchia di amici, il fondo di Georges Hérelle è composto da 950 titoli e diversi album fotografici raccolti durante i suoi numerosi viaggi in Europa e nel Maghreb.
I suoi pensieri raccolti nei taccuini rappresentano un documento inestimabile che descrivono perfettamente Hérelle come un uomo leale, attento, riflessivo, pacato, amante della natura, delle opere d’arte e soprattutto del pittoresco umano, poiché il presente sembra appassionarlo ancor di più del passato. È stata proprio questa sua smodata curiosità che lo spinge a offrirsi di tradurre in francese L’innocente (1892) di Gabriele d’Annunzio, allora apparso in puntate nel «Corriere di Napoli». Da quel momento comincia una fitta corrispondenza tra l’autore e il traduttore ricca di allusioni intime, sentimentali e politiche che lasciano trasparire un d’Annunzio in parte inedito con i suoi scoraggiamenti e con le sue ambizioni letterarie.

Notolette dannunziane è una raccolta di “ricordi, aneddoti e pettegolezzi” (citando testualmente il sottotitolo dell’opera) sulla figura di d’Annunzio, non solo attraverso le memorie e i diari di Hérelle, ma anche grazie alle informazioni passategli da alcuni degli amici più stretti del Vate, ovvero Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio e Guido Boggiani. Tale raccolta copre un periodo di oltre vent’anni a partire dal 1891 con la testimonianza della prima lettera in cui Hérelle chiede il permesso direttamente allo scrittore abruzzese di tradurre in francese L’innocente, fino al 1914 con una riflessione sulla svolta cinematografica di d’Annunzio con la sceneggiatura del film muto Cabiria.
È curioso osservare come i contatti tra i due s’interrompono decenni prima della morte dell’uno o dell’altro a causa di divergenze insorte in merito allo sperpero di denaro da parte di d’Annunzio e alla sua “superuomania” che lo aveva caratterizzato fin dall’adolescenza. Sebbene consapevole dei difetti del Vate, Hérelle non smette mai di stimare il Vate e continua ad ammirarlo: «Allorché Gabriele d’Annunzio non era ancora un superuomo era un più grand’uomo. Non solo non c’è niente di male a dirlo, ma sarebbe un male non dirlo»1G. Hérelle, Notolette dannunziane, a cura di I. Ciani, Pescara, Centro Nazionale di Studi Dannunziani, 1984, p. 10..
Questo progressivo allontanamento tra i due uomini di lettere sembra trovare un riscontro anche nell’andamento dell’opera che rispecchia perfettamente quest’involuzione. Dapprima, infatti, l’instaurarsi della loro amicizia si manifesta in quello che sembra un personalissimo diario di viaggio tra Venezia, l’Abruzzo, la Grecia e Parigi. Successivamente, vengono presentati stralci di lettere, riflessioni e annotazioni di tema letterario con interessanti spunti critici sulle ultime opere scritte e pubblicate dal Vate. Infine, le Notolette si chiudono con un resoconto impersonale e distaccato di alcune beghe giudiziarie che avevano coinvolto d’Annunzio, in primis sui diritti d’autore in Francia e sull’affare Del Guzzo. Tramite una lettera datata 1911, infatti, Hérelle chiede lumi a d’Annunzio che pare avesse venduto a terzi i diritti della traduzione francese di Giovanni Episcopo senza prima consultarsi né con Hérelle stesso (che deteneva la proprietà del testo in francese) né con la casa editrice Calmann-Lévy (che ne possedeva legittimamente i diritti)2Ibid., p. 133.. Inoltre, nel febbraio 1910, l’argentino Giovanni Del Guzzo offre a Gabriele d’Annunzio il suo aiuto per tirarlo fuori dalle difficoltà finanziarie attraverso un patto in undici articoli, con il quale Del Guzzo s’impegna a liquidare i debiti del Vate in cambio di diciassette manoscritti autografici, un’auto di marca Florentia, un’ode al presidente della Repubblica Argentina e un tour di almeno venti conferenze a Buenos Aires e in altre città argentine. Pare tuttavia che sin dal momento in cui firmano questo accordo, Del Guzzo si serve del nome di d’Annunzio per pianificare una fruttuosa impresa nell’America del Sud, mentre d’Annunzio chiede a Del Guzzo il pagamento dei propri debiti con l’obiettivo recondito di non rispettare le clausole, almeno per quel che concerne l’ode e la serie di conferenze3Ibid., pp. 139-140..
Indubbiamente godibile e appassionante, Notolette dannunziane potrebbe tuttavia mettere in discussione il realismo di quanto riportato da Hérelle. Se la precisa trascrizione delle lettere rappresenta un documento inconfutabile e veritiero, lo stesso non si può affermare delle ricostruzioni di intere conversazioni con d’Annunzio o con altri personaggi a lui vicini, in quanto è evidente che Hérelle non abbia potuto materialmente annotarsi tali colloqui se non in un secondo momento, «quando mi veniva la fantasia di fissare un ricordo»4Ibid., p. 7. come specificato da lui stesso nell’avvertenza iniziale dell’opera. Dunque, fin dove si spinge la realtà dei fatti? È possibile che Hérelle abbia romanzato la verità? Pagine intere di monologhi del Vate5Ibid., pp. 30-32. rispecchiano tuttavia dei vaneggiamenti e dei deliri in pieno stampo dannunziano, trasportando il lettore nella carrozza in cui si trovano il traduttore francese e lo scrittore abruzzese, e assistendo così agli impeti a tratti spassosi che denotano il carattere e l’essere del primo d’Annunzio esteta.
Con uno stile autentico, familiare e spontaneo, Georges Hérelle è stato capace di rendere accessibile la sfera privata di Gabriele d’Annunzio ritraendolo senza filtri e di regalare stralci della propria vita a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, tra le amicizie passeggere e un mestiere oneroso che forse, senza i giusti agganci, non gli avrebbe permesso di scoprire i segreti di uno dei personaggi più complicati e controversi della Storia d’Italia.
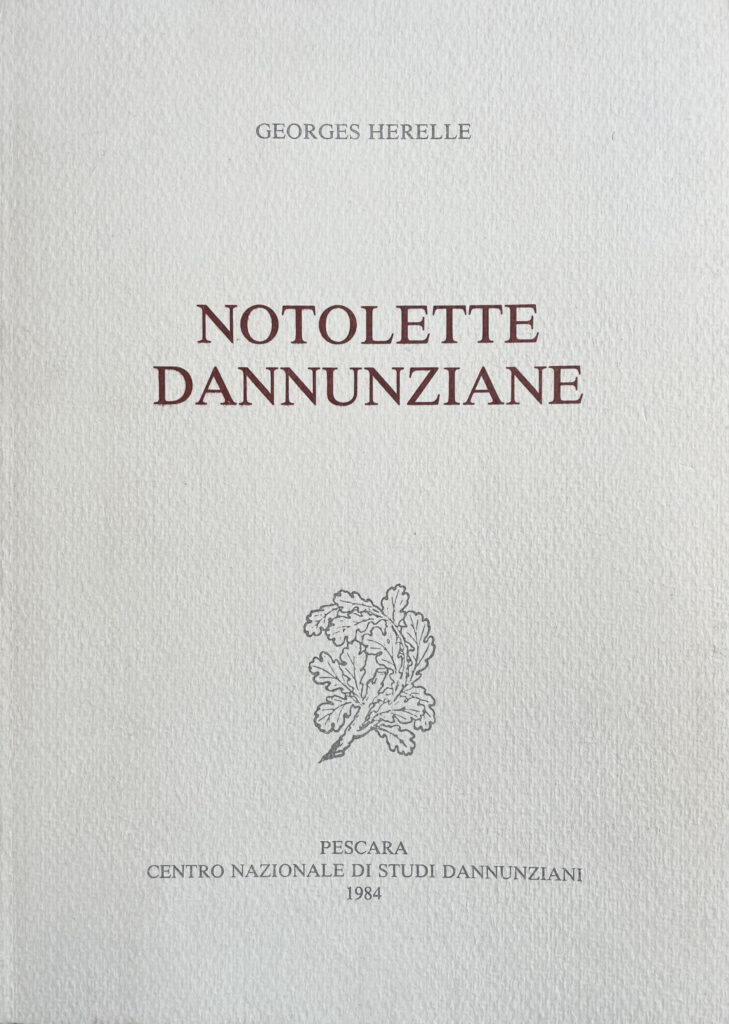
Georges Hérelle
Notolette dannunziane
prefazione di Guy Tosi, note di Ivanos Ciani
Centro Nazionale di Studi Dannunziani, 1984, pp. 166
acquistabile qui