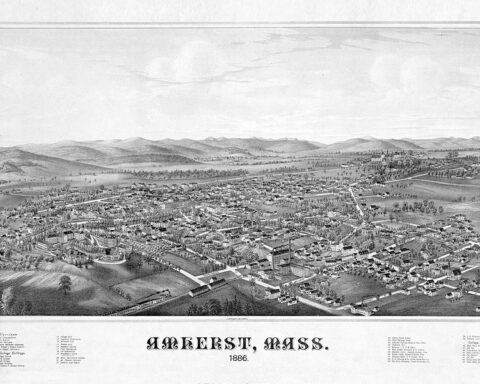Il poeta di guerra
Possedeva tutti gli attributi del prode: un cuor di leone mosso da indomabile orgoglio, un fascino da semidio norreno, infine gli onori dei caduti a sancirne la gloria eterna. Prima del suo tempo, la morte l’avrebbe chiamato, e sotto i bagliori del successo, il nobile poeta inglese Rupert Chawner Brooke (noto ai più come l’autore di The Soldier) se ne andava a soli ventisette anni, nel sole dell’aprile 1915, alla volta di Gallipoli. Promosso prematuramente al grado di sottotenente nei reparti di riserva della Royal Navy, il celebre soldato di Rugby sarebbe diventato presto un mito, un eroe di guerra. A grandi lodi lo descrisse il primo Lord Winston Churchill nel suo solenne “In Memoriam”, stampato sul «Times» pochi giorni dopo la tragica fine sull’isola di Sciro in Grecia, dove fu sepolto dai più fedeli compagni in armi.
Annunciando al paese intero la dolorosa perdita di una voce nazionale e lamentando al contempo la scomparsa di una intera generazione di giovani inglesi, il volto iconico del lontano disparu arrivava chiarissimo in patria:
Intrepido, versatile, profondamente istruito, con classica simmetria di mente e corpo, dominato da uno scopo alto e indubbio, era tutto ciò che si potrebbe chiedere ai più nobili figli d’Inghilterra in giorni in cui nessun sacrificio è il più accettato quanto quello offerto volontariamente.
Dietro di sé, il giovane poeta-soldato aveva lasciato un’ultima manciata di versi e una raccolta di sonetti vergati sotto l’anno ‘1914’ – divenuti poi bestseller (con la pubblicazione postuma di 1914 & Other Poems) – ancor prima di conoscere l’orrore del Fronte occidentale.
Il mito
Se da un lato la sua poesia spargeva esultanti spinte d’amor patrio e toni trionfanti condivisi appieno in Inghilterra e in altri paesi europei all’inizio della compagna, dall’altro la sua stessa immagine pubblica s’imprimeva nella memoria della nazione, pronta a resistere e a sfidare il tempo nel segno dorato dei suoi stessi versi. Da allora, il suo nome e il suo corpo sarebbero stati offerti come cibo per memoriali ed epitaffi, così come prescriveva la leggenda a cui la morte – pur lontana dalle trincee – lo eleggeva, costruendo à point la sua icona nazionale abilmente distorta dalla propaganda militarista. Feticcio di un’epoca imperialista e figlio di un culto vittoriano della guerra tornato da poco in auge, il suo ricordo andava suggellato nella memoria collettiva intorno al fascino dell’eroe-fanciullo dato in pasto all’Orco nel fiore dell’età, dipinto fin da subito sotto gli aspetti dell’ideale cavaliere moderno – erede di Byron e di Sidney – a personificazione dell’eroe romantico per antonomasia. Lodato a suo tempo come leale poeta armato della nazione, Rupert Brooke viene ricordato ancora oggi nelle più svariate antologie e storie della letteratura, più di tutto – oltre al raggiante talento dei suoi giorni georgiani – come poeta di guerra o, per meglio dire, l’incarnazione del poeta di guerra tout court. Uno dei pochi idealisti tra i violenti war poets britannici, ma anche il più immaturo del ricco plotone nazionale, il quale ebbe appena il tempo di sfiorare i combattimenti di Anversa per consegnare ai posteri una visione ardentemente patriottica, com’era immaginabile soltanto nei primi giorni dell’impresa.

Un ragazzo particolare
Eppure, alla Dichiarazione di guerra, il celebre poeta in armi rispose dapprima dubbioso alla possibilità dell’assoldamento. Il racconto di quel momento viene reso da Brooke stesso nelle pagine di un raro testo in prosa a carattere autobiografico, inedito in traduzione e presentato qui come Un ragazzo particolare (An Unusual Young Man, 1914). Composto allo scoppio del conflitto, venne inserito postumo all’interno della raccolta di resoconti di viaggio sui luoghi del tour che lo scrittore compì l’anno precedente in America del Nord, dal Canada agli Stati Uniti, fino al soggiorno nei Mari del Sud. Tra i suoi occasionali eppur consistenti esperimenti di prosa, il volume articolato in quindici scritti, pubblicati tutti postumi come Letters from America (1916), presentava una prefazione a firma di Henry James, il quale tributò al giovane poeta scomparso la sua ultima opera, dedicandogli un maestoso ritratto fisico e psicologico, dove ricorda l’effigiato come uno dei più dotati talenti poetici d’età georgiana, eletto a simbolo della “bionda gioventù” d’Albione: «Un tale ordine naturale dello spirito inglese, la tipica e straordinaria bellezza del fisico inglese, la più sofisticata concentrazione dell’intelletto […] l’ideale della gioventù d’Inghilterra».
L’esilio sentimentale
Difficilmente classificabile in una forma tradizionale, configurandosi bensì come un genere ibrido a metà tra un saggio autobiografico e una short story, il brano di chiusura della raccolta dichiara la vera posizione iniziale dell’autore verso la guerra. Di ciò, dunque, egli informa il lettore in un tono carico di dubbi, pensieri e sensazioni contrastanti che sommergono – a detta del narratore Brooke in persona – un suo caro amico, facendo così emergere, in sordina, il proprio punto di vista. Centrale nel racconto è il dissidio intimo di un giovane inglese amante della Germania, dall’animo diviso fra il dovere morale verso la patria e le proprie inclinazioni personali, messo davanti allo scoppio della prima grande guerra europea:
Gli balenavano in mente immagini confuse e provava una certa stanchezza. In risposta alla parola “Germania”, una trafila di ricordi sfocati si trascinavano nella sua testa. La pomposa volgarità middle-class dei palazzi di Berlino, l’immensa e serena bellezza di Monaco; il sapore della birra; innumerevoli cafés luccicanti e silenziosi; il Ring; la sferzata d’aria fresca della sera dritta in faccia mentre si scia in discesa davanti ai pini; un certo taglio d’occhi nel volto; lunghe notti di bevute e canti e risate; l’ammirevole bellezza delle mogli e madri tedesche; alcuni amici; qualche canzone; le serate tranquille sullo Starnberger See. Tra lui e il mare della Cornovaglia vide stendersi molto nitidamente dinanzi a sé una mattinata d’aprile su un lago a sud di Berlino […]. Si ricordò di una serata studentesca in una Kneipe a Monaco. Si erano scolati otto grosse pinte di birra una dopo l’altra, avevano fumato e intonato canzoni inglesi e tedesche in coro profondo. E quando il gruppo si sciolse, si ritrovò a braccetto con un ebreo gigante e un ragazzo dall’aspetto apollineo di nome Leo Diringer, il quale disse di essere un poeta.

Infatti, anche Brooke, come il contemporaneo Charles Sorley (caduto a Loos nel 1915, a soli vent’anni; si ricordi il suo inno all’internazionalismo To Germany), ammirava profondamente la cultura tedesca. Nel 1911 era a Monaco e l’anno dopo a Berlino, dove ebbe la fortuna di trovarsi a contatto con i circoli intellettuali e le avanguardie artistiche più floride di quegli anni.
Celebre è, a questo riguardo, la nostalgica ballata The Old Vicarage, Grantchester (1912), intitolata in origine Home e The Sentimental Exile. Tra le sue opere più lette e amate, la poesia venne composta durante il suo periodo berlinese nelle sale fumanti del famoso “Café des Westens”, all’epoca centro nevralgico di aggregazione della grande bohème, dove contrappone la radiosa bellezza e la lieta vita di campagna nella sua contea inglese alle caotiche atmosfere metropolitane d’area mitteleuropea:
Ebrei tedeschi bevono birra tutt’intorno;
— mentre lì morbide gocce di rugiada
Cadono da un cielo d’oro.
Qui i tulipani sbocciano come previsto;
Intorno a quelle siepi ondeggia selvaggia
Un’ufficiosa rosa inglese;
[…]
Oh! È forse fermo ancora il campanile, dieci minuti dalle tre?
Ed è rimasto del miele per il tè?
La recluta
Più avanti, nel testo del ‘14, dopo una vivida descrizione delle atmosfere di gioviale cameratismo trascorse nell’Europa d’anteguerra, si avverte un’agghiacciante premonizione della devastazione che sarebbe seguita, di lì a poco, sui campi delle Fiandre e altrove.
Una miriade di brevi immagini gli ruzzolavano per la testa, ma non portavano più con esse quell’aria di confortevole giovialità che la Germania aveva sempre significato per lui. Qualcosa dal profondo lo spingeva continuamente a pensare: “Devi odiare queste cose, devi trovare in loro qualcosa di malvagio”. C’era questa semicosciente agonia di spezzare un’abitudine mentale, coprendo i colori di un mucchio di associazioni, la stessa sensazione che aveva provato quando aveva smesso di credere nella religione o in maniera più intensa dopo un litigio con un amico. Sapeva che tutto ciò era assurdo. La scena che gli venne in mente fu il pensiero di incontrare l’ebreo o Diringer o il vecchio Wolf o il piccolo Streekmann, il pianista, durante un raid sulla costa orientale oppure sul continente, in una battaglia quasi fittizia, da teatro. Ridicolo. Immaginò vagamente tutta una serie di gesta eroiche, grandi imprese e l’applauso della folla…

Difatti, la retorica nazionalista in elogio del sacrificio bellico, tipica dei più citati sonetti, infiammerà in un secondo momento la sua scrittura. Nello stesso periodo, del resto, anche Siegfried Sasson – riconosciuto per il suo scottante realismo satirico come il più feroce war poet – provava esaltati sentimenti patriottici che avrebbe annotato in uno dei suoi memoir: «Dissi a me stesso che ero pronto ad affrontare qualsiasi cosa la guerra mi avesse chiesto» (The Weald of Youth, 1940). In An Unusual Young Man, invece, Rupert Brooke esprimeva precoci insicurezze all’interno di una prosa anch’essa sui generis, dietro cui si scorge, in filigrana, un urto malinconico scaturito dalla nostalgia per la spensieratezza della patria perduta. A tutti i suoi dubbi avrebbe dato risposta in tono fiero e definitivo, tuonando la recidiva di un’ingiunzione patriottica più antica, ovvero la «Vecchia Menzogna» del dolce morire in battaglia d’oraziana memoria, poi scardinata da Wilfred Owen (com’è noto, nella lirica Dulce et Decorum Est) e da altri poeti di guerra successivi.
Molti mesi prima dello sterminio sul crinale della Somme che li avrebbe attesi quasi tutti, il primo grido di guerra di Brooke non era altro, in questi termini, che la voce tremante di un profondo conflitto interiore risolto come meglio ci si poteva attendere dalla sua generazione:
Suppongo fosse consapevole di poche cose precise finché non ebbe raggiunto il treno per Londra. Continuava a tornargli alla mente, a malincuore, il ricordo di una mezzanotte durante il carnevale di Monaco, quando aveva intravisto un clown nei panni di Pierrot e una Colombina svoltare, delicatamente in punta di piedi, l’angolo di Theresienstrasse per poi svanire nell’oscurità. Così, pensò alle luci sul selciato di Trafalgar Square. Gli sembrò la cosa che più desiderava al mondo: immergersi nella mischia e parlare con una moltitudine di inglesi. Inoltre, ripeteva tra sé e sé – poiché era alquanto invidioso dei ragazzi tedeschi e francesi – “Be’, se la fine del mondo è vicina, credo proprio che bisognerà prendervi parte”. Non sapeva se essere contento o triste. Era una sensazione nuova.
Lontano dai toni enfatici e bellicosi della canonica serie di “sonetti di guerra” (The Treasure; I. Peace; II. Safety; III. The Dead; IV. The Dead; V. The Soldier), a cui si dedicò nell’autunno dello stesso anno, la futura recluta lascia qui traccia dell’unica motivazione patriottica tanto forte da spingerlo in guerra, accompagnato da migliaia di coscritti. L’«Armageddon» – così canzonava la sua visione dell’Apocalisse – era vicino ad abbattersi sul mondo, e lui l’avrebbe evitato ad ogni costo.
La scelta e la traduzione dei passi riportati è di Pierluigi Piscopo.
Pierluigi Piscopo (Napoli, classe 1997) è laureato in Lingue e Letterature Moderne Europee presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha discusso una tesi sulla poesia di guerra di Rupert Brooke, ed è appassionato di letteratura inglese, spaziando dall’età edoardiana al Modernismo. Scrive, traduce e viaggia in Gran Bretagna alla ricerca di libri, tè e scones. Ha dedicato altri articoli ad autori britannici, apparsi per «Pangea».